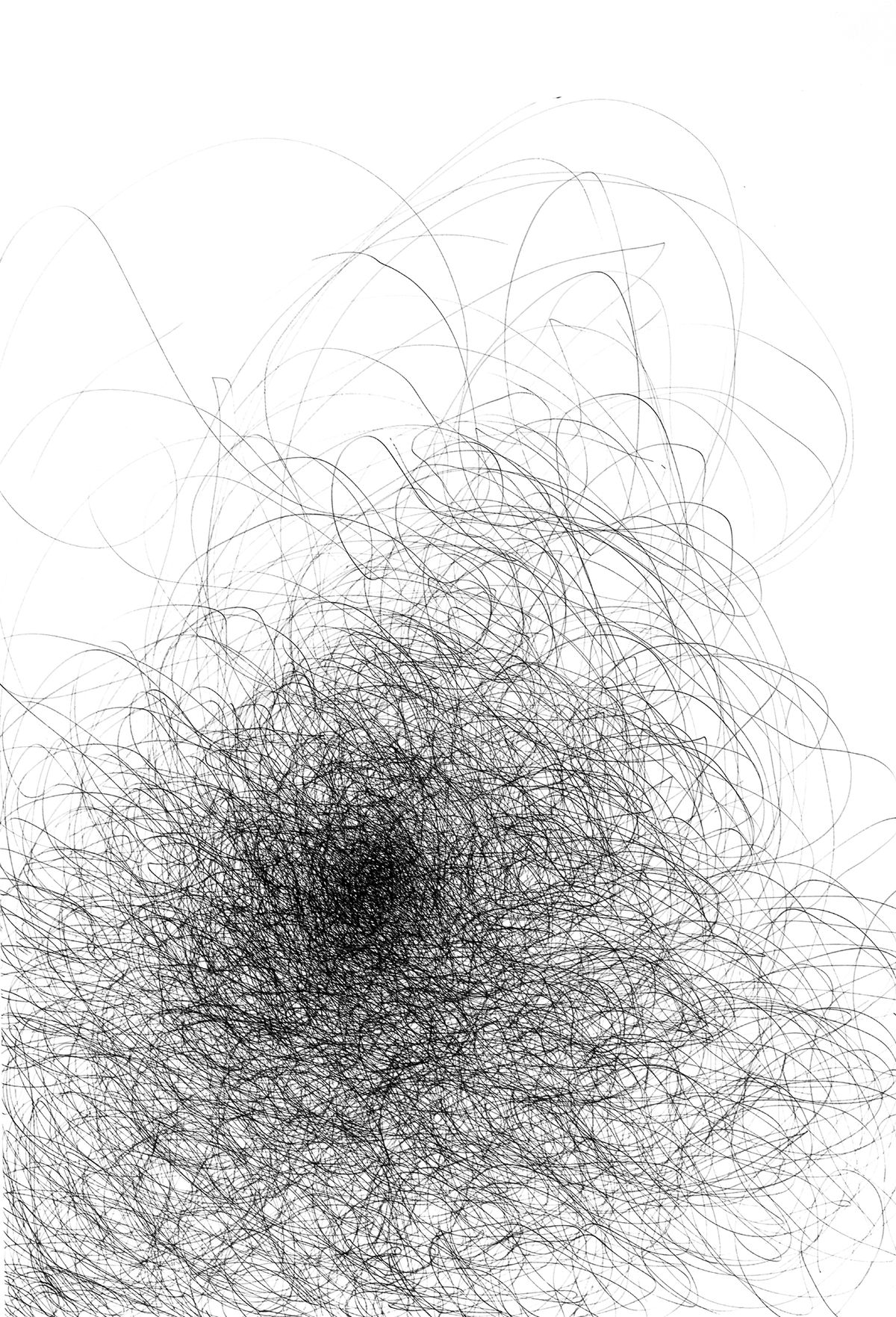(io, mio padre e l’Alzheimer)
La lotta col bastone
Giuggiù mio padre, era lì, piantato sulla poltrona. Donata da Biagio Conte tempo prima.
Non era neanche tanto anziano. Aveva solo 77 anni ma un corpo già devastato dalla malattia.
Le mani tremavano, le gambe molli come pane inzuppato, e la testa dondolava lenta, come se stesse cercando un centro che non trovava più.
Gli cadeva spesso in avanti, quella testa. Un colpo secco sul petto, come se volesse affondare dentro il torace per sparire. E allora bisognava sollevarla. Sempre.
Una, due, dieci volte al giorno. Un gesto apparentemente semplice, ma quando il collo non ti regge più e la mente se n’è andata a farsi fottere, anche tenere dritta la testa diventa un’impresa.
«Papà, la testa deve stare sù… forza!»
Lui reagiva con una smorfia. Un labbro violaceo, secco. Gli occhi persi in un punto qualsiasi del muro.
E poi c’era lui. Il bastone.
Un bastardo di bastone. Lungo, marrone, nevoso, storto. Con un manico consumato dall’uso e un odore addosso che non si capiva se fosse sudore, urina o morte.
Giuggiù non lo sopportava più.
«Ti ho dato tutto… porca troia… tutto! E tu adesso che fai? Mi abbandoni …»
Lo guardava come si guarda un nemico.
Lo afferrava, lo stringeva.
E ogni volta si trasformava in una battaglia surreale.
Era il suo compagno. Il suo nemico.
La sua croce.
A volte sembrava che quel bastone avesse una volontà propria. Che gli parlasse. “Dai, Giuggiù… alzati. Ce la puoi fare.”
E lui ci provava.
Spingeva, sudava, malediva ogni osso.
Ma alla fine si piegava, tornava giù, sconfitto. Il bastone cadeva a terra con un tonfo secco. Un colpo da pugile stanco. Giuggiù lo guardava da sotto in su, con odio.
«Vaffanculo…»
E piangeva. Non un pianto tenero, consolatorio. No. Un pianto convulso, sporco, rabbioso. Come se gli stessero rubando pezzo dopo pezzo la dignità.
Una volta provò a sollevarlo e il bastone scivolò via.
La testa colpì il bracciolo con un rumore sordo.
Rimase lì, rantolante, con la bocca aperta e la bava che colava sul mento. Lo raccolsi io. Gli misi il bastone in mano. Lo guardò, lo accarezzò quasi con dolcezza. Poi disse: «Io lo odio… ma non posso farne a meno.»
La mente ogni tanto tornava lucida. Frammenti. Schegge.
«Come ti chiami?»
«Sono tuo figlio, papà.»
«Ah… io la conosco?»
Si accarezzava la testa con la mano tremante, come se cercasse tra i capelli corti una risposta, un ricordo, una parola che lo riportasse a terra.
Poi rideva. Rideva di gusto. E con lui ridevo anche io. Ma avevo tanta voglia di piangere. Ridevamo del vuoto, del bastone, della merda, della vecchiaia. Ridevamo come si ride quando ormai non c’è più niente da perdere.
Un giorno mi disse: «Lo sai che il bastone l’ha portato tua madre, “Tienilo sempre con te”, mi disse. “Ti farà compagnia”.» Ma era un’immagine che non esisteva. Chissà da dove veniva quel non ricordo. Mia madre era morte da più di dieci anni..
Giuggiù abbassò lo sguardo.
Poi sussurrò: «Ma ora… è lui che comanda. Non io.»
Lo guardai. E capii.
Capii che quello non era più un bastone. Era diventato la sua ombra. Una protesi dell’anima. Una sentinella del tempo che non c’era più.
Una sera come tante me la ricordo come fosse adesso. Il cielo di Palermo era una coperta viola, senza stelle. Entrai nella stanza. Odore di disinfettante, piscio, aria ferma. Lui era lì, sulla poltrona, come sempre. Ma il bastone… non c’era. Lo trovai sotto il letto. Caduto. Abbandonato. O forse gettato via.
Giuggiù era nudo, avvolto da una coperta leggera.
Mi guardò.
Un attimo solo.
Uno sguardo lucido, feroce, vero.
Poi disse: «Sto arrivando. Bestia.»
La stanza di Giuggiù
La stanza di Giuggiù era come un’arena silenziosa, troppo grande per contenerlo davvero. La luce della primavera si infilava dalle finestre come una lama affilata, disegnando un fascio preciso che andava a infilarsi dritto sul letto. Giuggiù si svegliava di scatto, occhi spalancati, come se quella striscia luminosa lo stesse sfidando, invadendo il suo cervello con una forza che era più paura che conforto.
Parlava con quella luce, come se fosse un avversario, un falco che gli piombava dentro l’anima senza preavviso. Quelle parole erano solo sue, segrete e fragili, nessuno avrebbe potuto ascoltarle. Muoveva le mani in un balletto strano, tracciava linee invisibili: una stretta, un abbraccio, un cacciarsi via, un lasciarsi andare. Era il suo dialogo con il vuoto, un rito fragile e disperato.
Giuggiù veniva inghiottito da quella nuvola bianca, trasportato su un binario che stridendo lo portava lontano, sempre più lontano, verso un orizzonte senza confini, prima che l’ultimo tremito lo inghiottisse per sempre, senza più ritorno.
Accanto al letto, un divano consunto: era il suo rifugio quando riusciva a sedersi, aiutato da mani gentili. Davanti, una mensola costruita dal figlio, carica di medicine, aceticolina, noradrenalina, donepezil, memantina… Pillole inutili, ma l’alzheimer non ammette cure, solo una lenta distruzione: un morso maledetto chiamato “Beta-amiloide” che erodeva la sua mente e spegneva i pezzi di uomo dentro di lui.
Marcello, unico figlio, lo aveva accolto a casa dopo una breve sosta in una casa di riposo. Una vita normale, per lui: moglie, figli, bollette, scuola, comunioni. Il sud Italia in una scatola rassicurante.
Una sera, Giuggiù chiamò Marcello a casa. Gli disse che era certo: avrebbe finito i suoi giorni in una casa di riposo. La casa enorme, troppo vuota, era diventata una prigione di ricordi. “Vedo mamma,” mormorava, mentre il figlio lo guardava con occhi pieni di fastidio: “Ma dov’è? La mamma è morta, papà, da anni! Sei impazzito?”
Eppure lui la vedeva davvero: la moglie morta, attraversare il corridoio di quella casa mentre lui cercava di leggere l’ennesimo libro, o la settimana enigmistica scivolata via, il telefono che squillava nel vuoto, le strade diventate labirinti senza uscita, la pioggia che cadeva sul balcone mentre lui pensava che forse era il momento di mollare tutto.
Un mese in quella casa. Un mese in cui la memoria di Giuggiù oscillava tra lucidità e abisso. Sapeva ancora chi era, ma la casa non era quella che aveva immaginato. Niente svago, niente balli, e lui che amava ballare, diceva sempre: “Chi balla non muore mai.” Non capiva cosa fosse davvero una casa di riposo. Pensava agli anziani come i padroni della storia, degni di rispetto, ma non aveva idea di quella sofferenza profonda, di quell’esilio silenzioso.
Passava le giornate camminando senza meta nel corridoio, poi si sedeva all’ingresso, a guardare fuori. Aspettava che qualcuno venisse a liberarlo da quella prigione invisibile. Marcello veniva a trovarlo ogni giorno, ma Giuggiù era sempre lì, su quella panchina logora, una regina dimenticata di un regno spoglio.
Quando vedeva l’auto del figlio, gli occhi gli si illuminavano: “Finalmente, ora mi porta via…” diceva al compagno di sventura. Ma era solo un’illusione. Il colloquio quotidiano. Marcello sedeva con lui e con gli altri vecchi prigionieri di quella senilità, e pensava: “Se un giorno toccherà a me, forse è meglio morire prima.” Ma loro non lo sapevano, vivevano quel destino senza coscienza, e quell’attesa era l’unica certezza rimasta.
Un lento via vai di corpi che trascinavano il peso del mondo sulle spalle, occhi sgranati e tristi, panni intrisi di umori che tradivano il loro declino. Camminavano come spettri verso la luce, esiliati senza via d’uscita, digiuni di amore e di tempo.
Un giorno Giuggiù decise di andarsene. Propose a Marcello di tornare a casa con lui: “Non do fastidio, mi metti un letto in un angolo, mangio poco…” disse con gli occhi pieni di lacrime. Marcello esitò: “Non posso, papà, con Giusi e il bambino in arrivo, come faccio a pensare a te?”
Giuggiù cercò un fazzoletto nella tasca ma non lo trovò. La sua mano tremava, il pianto era muto, silenzioso. Marcello si fece forza, asciugò le lacrime del padre, e disse: “Va bene papà, dammi una settimana, ti porto via da questo inferno.”
In quell’istante padre e figlio si ritrovarono. Tutta una vita scivolava tra di loro, i vuoti si colmavano di parole taciute. Marcello decise: avrebbe preso cura di lui, fino alla fine.
Giuggiù e la pioggia
Il cielo nero si stendeva sulle finestre di quella stanza enorme, cumuli di nubi grigie e minacciose, come se pregassero un destino incerto. Giuggiù passava lì dentro quasi tutta la giornata, al massimo qualche pausa per mangiare. Quel mondo ristretto, racchiuso in quattro mura, era ormai la sua realtà.
Amava la pioggia, forse perché gli somigliava: cadeva stanca, come un’ultima disperazione scivolata dal cielo. Quel ticchettio sul vetro, a volte lieve e sommesso, altre volte violento, lo ipnotizzava. Lo rapiva. La pioggia trasformava il suo umore, quel malumore lunatico, in una specie di quiete. Il suono sui tetti delle macchine, sugli ombrelli aperti, una moto che scivola via, un uomo che si bagna tutto prima di chiudere la portiera dell’auto: piccoli scorci di vita che, in quel suo isolamento, lo ralleggiavano.
Spesso restava incollato alla finestra per ore, senza parlare, perso in quel mondo bagnato che odorava di terra fresca e di lacrime cadute dal cielo. La sua faccia, appoggiata al vetro, seguiva le gocce che correvano lungo il davanzale, tracciando rigagnoli fino a scomparire. Forse parlava con quella pioggia. O forse, in qualche frammento di lucidità, quella era l’unica cosa rimasta davvero sua, qualcosa che non si era ancora spenta dentro la sua testa. Forse erano quei bagliori rarefatti di memoria che lo riportavano indietro, quando, di mattina, intorno alle sei, usciva di casa per andare a lavorare.
La toilette mattutina era quasi un rito. Giuggiù restava davanti allo specchio almeno un’ora, La divisa scura sempre in ordine, i pantaloni mai fermi, che scendevano un po’ troppo o risalivano, come un’ossessione senza fine. Pensava di avere la pancia, come un tempo, ma non era così. Era solo la sua fissazione. Poi, magari, mentre aspettava il bus, pioveva, e tutta quella preparazione da vecchia diva andava a farsi fottere. Ma a lui andava bene anche così.
Marcello entrò nella stanza del padre. Era l’ora del pranzo. Non aveva voluto affidare Giuggiù a nessuna badante, nonostante le insistenze. Aveva preso ferie e deciso che sarebbe stato lui a occuparsi di tutto: padre, infermiere, figlio, marito. Come in una novella di Pirandello, aveva assunto tutte quelle parti in una sola figura.
Sul tavolino, un piatto concavo fumava: pastina in bianco con poco olio, poco sale, ma tanto formaggio il suo unico vizio. Marcello, goffo, fece cadere un po’ di brodo caldo sul polso sinistro.
«Cazzo, che caldo!» sbottò.
Ma l’odore del formaggio era così intenso che non resistette: con una lingua furtiva si leccò il polso, quasi di nascosto. Mentre assaporava quel sapore, si accorse degli occhi di Giuggiù, fissi su di lui. Uno sguardo indagatore, come a dire: «Che cazzo stai facendo? E io?»
Marcello sorrise, mentre una linguina scivolava da un angolo della bocca. Giuggiù, con un lieve accenno di sorriso, senza dentiera ormai, fece un gesto con la mano sinistra: sfiorò il braccio del figlio e si girò di lato, quasi per nascondere quel momento di fragile beatitudine.
Forse in quell’istante Giuggiù capì che quella figura accanto a lui, con il piatto fumante, era suo figlio. E Marcello capì che suo padre lo riconobbe, anche se solo per un attimo.
Quel giorno in ambulanza
Quel giorno arrivò l’ambulanza. A sirene spiegate si aprì un varco tra il traffico del mattino, dove le auto erano come persone ammassate in fila, come in una posta eternamente bloccata a pagare l’ultima bolletta della vita.
Giunse in pochi minuti all’ospedale, mentre Marcello inseguiva il padre sulla sua moto, come un fulmine impazzito che voleva arrivare prima della morte. Entrò in quella sala d’attesa intrisa di pietà appassita e freddezza d’animo, un posto dove l’aria pesava di attese inutili e voci rotte.
Era un caos controllato: camici bianchi che correvano, barelle che cigolavano, richieste d’aiuto soffocate nel nulla, un continuo “non fare” mascherato da “aspetta”.
«Papà, stai tranquillo, adesso ci chiamano…» Marcello mentì, perché era l’unica medicina che poteva somministrare in quell’ora disteso su una lettiga sgangherata.
Il cognome risuonò nella sala solo ore dopo. Giuggiù non era un codice rosso, né un giallo. Non era nemmeno un caso. Giuggiù era solo un malato di Alzheimer, e quindi non sei urgente.
Il neurologo che lo seguiva, uno di quelli che ti lascia la pietà fuori dalla porta, disse un giorno con voce piatta: «Non dia più medicine a suo padre, è denaro buttato, è in fase avanzata, lasci perdere».
Ma Marcello non buttò mai quelle medicine. Le allineava tutte sul mobile di fronte al letto, come fossero soldatini schierati per l’ultima battaglia, senza capire davvero perché. Ogni giorno le sistemava, con una precisione maniacale che non era sua: medicine da una parte, guanti di lattice da un’altra, alcool lì, pannoloni a sinistra, pigiami a destra, sacche raccogli urine sempre in vista, sempre sotto controllo.
Ogni giorno la stessa routine, ossessiva, un ordine che teneva a bada il caos dentro di lui.
Ma Marcello non dormiva più da tempo. Il sonno era a pezzi, fatto di risvegli improvvisi e quella voce che urlava nella notte, un’eco sfinita: «Papà! Papà! Dove sei?»
Giuggiù peggiorava, e la sera era un tunnel che Marcello era costretto a percorrere ogni maledetto giorno. Quando la poca cena finiva, si addormentava,a volte anche sulla sedia a capo tavola e Marcello, guardandolo, vedeva ancora suo padre, anche se non lo riconosceva più. Sempre suo padre, maledettamente suo padre, in quel dolore che cresceva come un cancro invisibile.
Marcello non aveva matite colorate per ridisegnare quel padre smarrito. Tra loro solo un silenzio fatto di urla senza voce.
Al pronto soccorso chiese l’intervento di uno psichiatra, dopo che i medici gli avevano detto che il padre stava bene, che era solo una crisi legata alla malattia e che poteva tornare a casa camminando. Ma Giuggiù non camminava più.
Marcello era sfinito. La famiglia allo stremo. Voleva solo qualche giorno, solo un paio di giorni di normalità, per mettere insieme i pezzi e respirare un po’. Chiedeva un ricovero temporaneo, un momento di tregua.
Lo psichiatra disse no.
Un no secco, totale.
E quella parola picchiò su Marcello come un ceffone.
Giuggiù quel giorno ebbe sete
«Voglio un po’ d’acqua fresca… fresca…» imprecava Giuggiù dal letto alle sette del mattino.
Marcello, il giorno prima, aveva deciso di tornare al lavoro. Erano mesi che non ci andava più, si era preso ferie lunghe, giorni festivi da recuperare. Gli mancava l’aria, il contatto con il mondo fuori, la normalità. Aveva fame di quel lavoro che ora gli sembrava l’unica porta verso la luce, un modo per tornare a vivere.
Quella mattina Giuggiù aveva una sete strana, urlava che voleva bere. Marcello, che doveva andare al lavoro nel pomeriggio, gli portò un bicchiere d’acqua fresca. «Tienilo, papà, ma bevi piano, non ingozzarti» gli disse.
Infilò la mano destra sotto la nuca del padre, sollevando quella testolina bianca verso il bicchiere. Giuggiù bevve tutto d’un fiato, senza pausa. Quando finì, sospirò a lungo e disse: «Grazie».
Quel giorno Giuggiù era strano. Seguiva il figlio mentre rimetteva tutto in ordine nella stanza. La moglie in cucina allattava l’ultimo arrivato, gli altri figli correvano da una stanza all’altra. Marcello osservava il padre: occhi socchiusi, ma non dormiva come al solito. Anche lui lo fissava, con lo sguardo abbassato, come se volesse tener strette quelle ultime immagini.
Giunse l’ora del pranzo e Marcello, come da mesi ormai, portò il piatto di minestrina al pomodoro che al padre piaceva tanto. Sollevò Giuggiù, mise cuscini dietro la schiena, gli avvolse un lungo bavaglio intorno al collo e si sedette sul bracciolo del letto, pronto a quel rito quotidiano. «Dai papà, apri la bocca, non è nemmeno calda… senti che profumo…», ripeteva sempre le stesse parole, giorno dopo giorno. Giuggiù apriva la bocca e obbediva.
Ma quel giorno non volle mangiare. A mala pena mandò giù un cucchiaio di pastina e poi disse: «Basta… non ne voglio più».
Marcello pregò, supplicò: «Che fai? Non hai più fame? Dai, apri la bocca, devi mangiare, non puoi stare digiuno…».
Non capiva cosa stava succedendo in quel momento, a quell’ora precisa, le 13.25 di un 14 giugno qualsiasi, in una stanza qualunque, in un mondo qualunque.
Un brivido gli corse lungo la schiena quando vide il padre chiudere la bocca, girarsi di scatto e fissarlo con quegli occhi cerulei, cristallini, pieni di parole mai dette.
In un attimo nella mente di Marcello scorsero immagini: treni di prima mattina, occhi incantati, nubi, strade, amori e odi, vite spezzate e sogni svaniti.
Una folata di vento freddo invase la stanza, nonostante il sole quasi estivo filtrasse tra le tende. Era una luce che si infilava dentro quel letto di morte. Marcello guardava quel padre che non urlava più, che non lo riconosceva, che aveva sconvolto i suoi ultimi mesi e forse l’intera vita.
Il buio lo avvolse improvviso, e sentì la moglie stringerlo a sé: «Marcello, hai fatto tutto quello che potevi. Sei stato con tuo padre nel momento migliore», diceva lei, cercando di consolarlo. Ma Marcello si sentiva vuoto dentro, come se gli avessero strappato l’anima, come se un ghiaccio perforasse il suo cuore.
Piangeva.
Solo, di spalle al padre, vicino alla finestra di quella stanza.
Piangeva guardando la strada, le auto che passavano, il cielo azzurro, il sole d’inizio estate.
Piangeva sentendo quel profumo intenso di ginepri, senza fiato, senza respiro.
A volte mi immagino sulla spiaggia, a mezzanotte o giù di lì.
Non c’è nessuno, neanche la luna a farmi compagnia, solo il frastuono del mare.
A volte vedo forme scure, umane, sdraiate sulla sabbia, che scrivono parole incomprensibili.
Vorrei che quelle parole raggiungessero chi ora non c’è più.
Vorrei che sentissero il mio dolore, che rispondessero al richiamo della mia coscienza.
Vorrei che un giorno un fugace arcobaleno scavasse tra i miei ricordi incustoditi…
@2007 – 2025